
Il diritto all'istruzione
Che cosa si intende per “diritto all’istruzione”?
Diritto all'istruzione, all'educazione o allo studio: comunque lo si chiami, rimane un principio alla base di qualsiasi democrazia.
Sancito come diritto umano nel 1948 sia dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sia dalla Costituzione italiana, il diritto all’istruzione è un diritto fondamentale, che garantisce a ogni individuo la possibilità di accedere a un’educazione adeguata e di qualità.
Questo diritto è essenziale per lo sviluppo personale, sociale, culturale ed economico delle persone e delle comunità ed è fondamentale per garantire l’uguaglianza e la dignità di tutte le persone.
Ma cosa s’intende per “diritto all’istruzione”?
Il diritto all’istruzione può essere definito come il diritto allo studio, all’apprendimento, a crescere culturalmente e a sviluppare le proprie capacità e inclinazioni: un diritto che compete all’individuo in quanto tale, senza distinzioni di razza, sesso, nazionalità, etnia o origini sociali, preferenze religiose o politiche, età o invalidità.
E la scuola dovrebbe essere “l’apparato preposto a erogare il servizio di istruzione e a perseguire il diritto all’apprendimento, composto dalla comunità educante, retto dal dirigente scolastico e dagli organi collegiali, con un ordinamento definito dalle norme del diritto scolastico relative agli istituti di cui è responsabile e da regole proprie, adottate in autonomia e indirizzate a favorire il migliore esercizio delle funzioni.”
(La tarda realtà delle nostre "Indicazioni")
E poiché ogni diritto implica un dovere, il sistema scolastico ha il dovere di garantire sempre il diritto all’istruzione di tutti.
Un esempio molto attuale è dato dall’uso degli strumenti compensativi: “… se essi rientrano nelle «azioni positive» in favore degli alunni con BES e rappresentano un diritto per gli alunni con disabilità o per gli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento, sono soprattutto uno strumento didattico che nessuna norma vieta di utilizzare, a discrezione, per ogni altro alunno. Perché la finalità dell’azione didattica non è riempire un PEI o un PDP di crocette, ma di favorire l’acquisizione degli obiettivi di apprendimento”.
(La scuola di carta, la scuola di persone)
Ma non tutti i sistemi scolastici tutelano il diritto all’istruzione: infatti, secondo i dati UNESCO riferiti al 2023, nel mondo ci sono ancora 244 milioni di minorenni che non vanno a scuola.
I fattori di esclusione sono molteplici:
- povertà economica;
- guerre e instabilità politica;
- discriminazioni basate su genere, etnia o disabilità;
- mancanza di infrastrutture;
- barriere architettoniche;
- malattie, malnutrizione e mancanza di servizi sanitari adeguati.
(Il diritto all’istruzione dei bambini e la sua tutela nel mondo)
A livello internazionale, il diritto all’istruzione ha trovato un primo riconoscimento esplicito con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dall’ONU nel 1948, ed in seguito, con il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 e con la Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia del 1989.
Infatti, il tema del diritto all’istruzione, presente all’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, rappresenta ancora oggi la pietra miliare quando si parla di diritti umani.
“Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e di base. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.”
Come si può notare, nell’art. 26 ci sono tutti gli elementi principali del diritto all’istruzione:
- accesso universale: ogni persona, indipendentemente da genere, origine etnica, status economico o altre condizioni, deve avere la possibilità di frequentare la scuola;
- gratuità e obbligatorietà: in molti Paesi l’istruzione primaria è gratuita e obbligatoria, per garantire che nessun bambino venga escluso per motivi economici. In Italia, ad esempio, l’istruzione è obbligatoria fino a 16 anni;
- qualità dell’istruzione: il diritto non si limita alla frequenza scolastica, ma include anche la necessità che l’educazione sia di qualità, con insegnanti qualificati, risorse adeguate e programmi che promuovano lo sviluppo delle competenze fondamentali;
- non discriminazione: l’istruzione deve essere accessibile senza alcuna forma di discriminazione;
- libertà educativa dei genitori: include il diritto dei genitori di scegliere l’educazione dei propri figli (ad esempio scuole pubbliche o private) e il diritto alla libertà di insegnamento.
(Il diritto all'istruzione e la sua tutela, dal mondo all'Italia)
Il diritto all’istruzione è ancora più importante quando viene concretamente garantito alle fasce più povere della popolazione, per le quali la conoscenza rappresenta una vera e propria possibilità di riscatto. Però, nonostante i progressi degli ultimi decenni, milioni di bambini e ragazzi nel mondo continuano a vedersi negato questo diritto.
“Si stima infatti che, a livello globale, circa 617 milioni di bambini e adolescenti non siano in grado di leggere, scrivere o eseguire operazioni matematiche di base. Questo nonostante i due terzi di loro frequenti regolarmente la scuola.
(Diritto all'istruzione nel mondo)
Oggi, il diritto all’istruzione è parte integrante anche dell’Agenda 2030, un programma d’azione volto a promuovere il benessere delle persone e la salvaguardia del pianeta, con il quale nel 2015 i governi di 193 Paesi membri dell’ONU si sono impegnati al raggiungimento di obiettivi concreti di sviluppo sostenibile. In particolare, l’Obiettivo 4 dell’Agenda 30 impegna gli stati ad “assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento per tutti”, eliminando qualsiasi forma di discriminazione di genere e promuovendo l’uguaglianza nell’accesso all’istruzione di alta qualità.
(Approfondimento nello scaricabile 2_ L'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030)
Ma come si è sviluppato il diritto all’istruzione nella storia?
Il diritto all’istruzione ha compiuto nel tempo progressi significativi, passando da un privilegio riservato a pochi a un diritto universale. La sua evoluzione è strettamente legata ai cambiamenti politici, sociali e culturali della storia.
Ecco un breve excursus che ne ripercorre le tappe principali!
Antichità
- Civiltà mesopotamiche, egizia e greca: l’istruzione era riservata a élite sociali, come sacerdoti, scribi e aristocratici. Nella Grecia classica, però, si iniziò a promuovere un’idea più ampia di educazione, legata alla formazione dell’uomo come cittadino, soprattutto ad Atene. Platone e Aristotele definirono l’educazione come strumento per la crescita morale e intellettuale.
- Impero romano: l’istruzione era limitata ai figli delle classi più agiate. Era organizzata in scuole private e centrata su grammatica, retorica e diritto. L’educazione delle masse era trascurata.
Medioevo
- Istruzione religiosa: la Chiesa giocò un ruolo predominante, gestendo scuole nei monasteri e nelle cattedrali per formare sacerdoti e funzionari. Le università medievali (come Bologna, Parigi e Oxford) nacquero come centri di studi superiori, accessibili solo a pochi.
- Popolazione generale: l’analfabetismo era diffuso tra le classi più basse, mentre l’istruzione dei bambini era spesso delegata alla famiglia o a forme di apprendistato.
Età moderna
- Riforma protestante (XVI secolo): la diffusione dell’istruzione divenne una priorità per i riformatori come Lutero, che ritenevano essenziale che ogni cristiano fosse in grado di leggere la Bibbia.
- Illuminismo (XVIII secolo): in questo periodo si diffuse l’idea di un’educazione accessibile a tutte le classi sociali e filosofi come Rousseau e Condorcet sottolinearono l’importanza dell’istruzione pubblica per promuovere uguaglianza e progresso.
- Rivoluzione industriale (XVIII-XIX secolo): la necessità di una forza lavoro istruita portò i governi a istituire le prime scuole pubbliche. In molti Paesi europei nacquero leggi per rendere obbligatoria l’istruzione primaria.
Età contemporanea
- XIX secolo: in Italia, la legge Casati (1859) introdusse un primo sistema di istruzione pubblica, prevedendo l’obbligo scolastico, seppure limitato a pochi anni.
- XX secolo:
- Dopo la seconda guerra mondiale, l’istruzione venne riconosciuta come diritto universale. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) affermò che “ogni individuo ha diritto all’istruzione”.
- L’Italia approvò la Costituzione (1948), che sancisce il diritto all’istruzione gratuita e obbligatoria.
- Le organizzazioni internazionali come l’UNESCO iniziarono a lavorare per garantire l’accesso all’istruzione nei Paesi in via di sviluppo.
- XXI secolo:
- La globalizzazione e le nuove tecnologie hanno ampliato l’accesso all’istruzione attraverso strumenti digitali.
- Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030) oggi includono il diritto all’istruzione di qualità per tutti.
E il diritto all’istruzione nella Costituzione italiana?
In Italia, il diritto all’istruzione è sancito dalla Costituzione del 1948 e regolamentato da specifiche leggi che ne definiscono l’organizzazione e l’obbligatorietà.
La Costituzione promuove l’accesso universale all’istruzione, sottolineando l’importanza di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che possano limitarne la fruizione.
I fondamenti costituzionali sono rappresentati dai seguenti articoli:
- Articolo 33: Stabilisce la libertà di insegnamento e il diritto di enti e privati di istituire scuole senza oneri per lo Stato. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
- Articolo 34: Afferma che “La scuola è aperta a tutti”. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, con il supporto di borse di studio e altre provvidenze attribuite per concorso.
(Approfondimento nello scaricabile 1_ Il diritto all'istruzione nella Costituzione italiana)
Ricordiamo che anche i genitori hanno il diritto-dovere di istruire i figli!
Lo afferma l’articolo 30, comma 1, della nostra Costituzione : “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”.
Affinché i genitori adempiano tale dovere, lo Stato è tenuto a predisporre apposite strutture: cioè ad istituire proprie scuole per ogni ordine e grado (Costituzione, art. 33, comma 2).
Per quanto riguarda la scuola dell’obbligo, i genitori devono garantire ai figli la frequenza scolastica. Nel caso in cui la famiglia versi in buone condizioni economiche, deve essere assicurata ai figli e alle figlie anche la possibilità di proseguire gli studi alla scuola secondaria. Infine, il dovere di istruire i figli si concretizza con l’obbligo ed il diritto dei genitori di prendere parte alla vita scolastica attraverso una collaborazione attiva con il personale docente e, in generale, con l’istituto.
Per quanto riguarda la struttura del sistema educativo italiano, oggi è articolato in diversi cicli:
- Istruzione obbligatoria: ha una durata di 10 anni, dai 6 ai 16 anni di età, e comprende:
- Primo ciclo di istruzione: otto anni suddivisi in cinque anni di scuola primaria e tre anni di scuola secondaria di primo grado.
- Primi due anni del secondo ciclo: possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
- Secondo ciclo di istruzione (dopo i 16 anni):
- Scuola secondaria di secondo grado: di durata quinquennale, con indirizzi liceali, tecnici e professionali (il biennio iniziale rientra nell’obbligo scolastico).
- Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP): di competenza regionale, con durata triennale o quadriennale, finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali (il biennio iniziale rientra nell’obbligo scolastico).
- Istruzione terziaria: include università, istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Oltre all’obbligo scolastico fino a 16 anni, in Italia vige il diritto-dovere all’istruzione e formazione per almeno 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età. Questo principio mira a garantire a tutti i giovani l’acquisizione di competenze fondamentali per l’inserimento nel mondo del lavoro e nella società.
La politica scolastica italiana vera e propria ha avuto inizio con la Legge Casati del 1859: dopo abbiamo assistito a tutta una serie di emendamenti, più o meno interessanti e non sempre adeguati, che hanno portato il nostro sistema scolastico alla situazione attuale.
(Approfondimento nello scaricabile 1_ Il diritto all'istruzione nella Costituzione italiana)
Inoltre, occorre sottolineare che il sistema educativo italiano si impegna da anni a garantire l’inclusione e a rispettare le diversità, assicurando pari opportunità a tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro origine o condizione sociale. Però, persistono ancora disparità territoriali, con differenze marcate tra le regioni del Nord e del Sud, e problematiche legate all’abbandono scolastico. Occorre, quindi, affrontare ancora queste sfide per assicurare che il diritto all’istruzione sia pienamente realizzato in tutto il Paese.
Il Rapporto ASviS 2023 attesta che tra il 2010 e il 2022 il Goal 4 previsto dall’Agenda 30 (Agenda 2030: che cos’è e come spiegarla ai nostri studenti) sta migliorando: aumentano infatti i laureati e diminuiscono le persone che escono precocemente dal sistema di istruzione, ma crescono anche le disuguaglianze tra le regioni italiane. Il 2020, causa pandemia, ha provocato un netto peggioramento delle competenze, ma dal 2021 l'indice ha ripreso a crescere.
Il Rapporto evidenzia, però, come il nostro Paese sia ancora lontano dai target europei per i servizi per la prima infanzia: “… i posti disponibili hanno servito il 28% dei bambini e delle bambine fino a tre anni compiuti, anche se gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dovrebbero puntare all’obiettivo europeo del 33% entro il 2026. L’11,5% dei ragazzi e delle ragazze tra 18 e 24 anni è uscito, senza diploma, dal sistema di istruzione e formazione, a fronte di una media europea del 9,6%. Questo fenomeno coinvolge maggiormente i ragazzi (13,6%) rispetto alle ragazze (9,1%). Per la cittadinanza straniera sale in media a quota 36,5%. La percentuale di early leavers è comunque in diminuzione nel nostro Paese, ma rimangono profonde differenze a livello territoriale: le regioni del Mezzogiorno presentano un tasso di abbandono del 15,1%, rispetto all’8,2% del Centro e al 9,9% del Nord.”
(Dispersione scolastica la più grave emergenza educativa del nostro Paese)
E per gli studi superiori?
Una ricerca svolta nel 2023 dall’Osservatorio Futura su “Giovani e diritto allo studio” sulla popolazione italiana di età 18+ ci dice che nell’ultima parte del percorso scolastico il diritto allo studio è garantito solo per il 10% degli intervistati e rappresenta quindi un vero e proprio “fardello” per le famiglie. Il supporto dei genitori è indispensabile nella vita degli studenti per il 90% del campione.
Insomma, in Italia studiare costa, mentre il diritto all’istruzione è un valore costituzionale e dovrebbe essere garantito a tutte e a tutti.
Per garantire il diritto allo studio anche dopo l’obbligo scolastico occorrerebbero più borse di studio ed esoneri, parziali o totali, dal pagamento delle tasse per gli universitari, sostegno per i trasporti e per gli eventuali alloggi …. : un vero e proprio piano di investimento in grado di rendere l'università gratuita e accessibile.
Certamente un’istruzione di qualità è fondamentale non solo per garantire il diritto allo studio di tutti, ma anche perché è considerata la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere uno sviluppo sostenibile.
BIBLIO/SITOGRAFIA
- Gaetano Bonetta, Storia della scuola e delle istituzioni educative. Scuola e processi formativi in Italia dal XVIII al XX secolo, Firenze, Giunti, 1997
- Giovanni Genovesi, Storia della scuola in Italia dal Settecento a oggi, Laterza, Roma-Bari, 2006
- Roberto Renzetti, Le riforme della scuola dal 1969 a oggi
- Il percorso evolutivo del diritto all´istruzione: dalla costituzione ai giorni nostri, CamminoDiritto.it
- Breve storia della scuola italiana: com’è cambiata dal Medioevo a oggi
- Il diritto all'istruzione e la sua tutela, dal mondo all'Italia
- Diritto all’istruzione nel mondo
- Dispersione scolastica la più grave emergenza educativa del nostro Paese
A cura di Viviana Rossi e Maria Enrica Bianchi

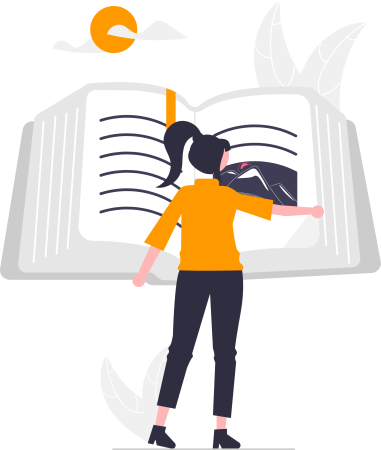

Sei un insegnante?
Scopri la nuova sezione Fai una domanda alle nostre autrici.
Sarà possibile porre alle autrici del blog, Enrica Maria Bianchi e Viviana Rossi, domande di approfondimento sui vari articoli, compilando un semplice form!
Domande e risposte saranno rese pubbliche.
*Per accedere alla sezione usa le tue credenziali Lattes. Se non sei ancora registrato clicca qui!



