
Sulla strada delle nuove Indicazioni nazionali
Luci e ombre nelle nuove Indicazioni nazionali 2025
L’11 marzo 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha reso disponibile la bozza del nuovo testo delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, che sostituiranno quelle attualmente in vigore, adottate nel novembre 2012 e aggiornate nel 2018 (Indicazioni nazionali e nuovi scenari) con l’obiettivo di adeguare l’insegnamento alle evoluzioni sociali, culturali, tecnologiche ed economiche della nostra società.
La pubblicazione del documento ha dato il via ad una fase di consultazione che la commissione ha effettuato mediante incontri con le associazioni professionali e disciplinari, con le associazioni dei genitori e degli studenti, con le organizzazioni sindacali della scuola e con un questionario ai docenti.
Un momento epocale nel modo della scuola in quanto le Indicazioni nazionali sono il cuore della scuola: un passaggio importante che ha delle conseguenze non solo nel mondo scolastico, ma anche nella vita di tutti i giorni, in quanto si parla di conoscenze e di competenze che tutti i nostri studenti e le nostre studentesse devono poter acquisire per andar incontro ai rapidi cambiamenti di questa nostra società.
“È stato un lavoro enorme, iniziato ad agosto 2023 e ancora in corso, che ha visto collaborare pedagogisti, esperti disciplinari e rappresentanti del mondo scolastico, afferma la dottoressa Loredana Perla, pedagogista, coordinatrice della Commissione ministeriale per la revisione delle nuove Indicazioni nazionali. “Non siamo partiti dal nulla, ma da un’attenta analisi comparata con i sistemi educativi europei e internazionali, raccolta in un corposo volume di oltre 350 pagine”.
Il risultato è un documento di circa 150 pagine (destinato a essere ulteriormente affinato, al termine delle consultazioni e dopo aver sentito i pareri delle scuole), che presenta alcune novità attorno alle quali è nato un vero e proprio dibattito nel mondo della scuola e non solo.
Infatti, le nuove Indicazioni nazionali sono state accolte con un diverso grado di apprezzamento e differenti opinioni.
Dopo le osservazioni critiche emerse da ambienti accademici e disciplinari, a prendere posizione in modo compatto sono anche alcune società disciplinari, ad esempio quella di Storia, che denuncia una visione troppo ideologica dell’insegnamento della Storia, troppo orientata alla costruzione dell’identità nazionale.
(Approfondimento nello scaricabile 1_La Storia nelle nuove Indicazioni Nazionali 2025)
Una volta rivisto, il testo definitivo sarà validato e trasmesso alle scuole (e alle case editrici per l’aggiornamento dei libri di testo) nell’intento di farlo entrare in vigore con l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027.
Ma era proprio necessario rinnovare le Indicazioni nazionali del 2012?
“Dopo 13 anni, era necessario. Lo abbiamo fatto pensando alla scuola reale, ai suoi problemi concreti, alla fatica quotidiana degli insegnanti. Ora tocca al Paese intero fare la sua parte” afferma la coordinatrice Perla in un’intervista durante un convegno romano promosso dalla sottosegretaria Paola Frassinetti.
(Nuove Indicazioni Nazionali, possibili modifiche: saranno recepite le osservazioni arrivate. Perla: “Genitori sottovalutano il lavoro dei docenti”)
Secondo Italo Fiorin, coordinatore della Commissione del 2007 e del gruppo di lavoro che ha seguito l’implementazione delle Indicazioni nazionali per infanzia e primo ciclo vigenti, si poteva fare un lavoro di aggiornamento come quello che era stato fatto dal 2012 al 2018. Sarebbe forse bastato integrare le competenze digitali e di cittadinanza che nel 2012 non erano ancora così ben delineate dai framework europei (Digcomp 2.2).
Invece, siamo di fronte ad una vera e propria revisione, con un’impostazione che potrebbe far pensare più a Programmi che a Indicazioni, quindi più a un documento prescrittivo che a uno strumento flessibile funzionale all’autonomia scolastica, autonomia di cui godono le istituzioni scolastiche dal DPR 275/1999.
Ricordiamo che Indicazioni e Programmi non sono sinonimi.
La differenza non è solamente terminologica ma sostanziale: i Programmi erano prescrittivi e obbligatori, mentre le Indicazioni definiscono obiettivi generali e traguardi di apprendimento… ma non parlano mai di contenuti obbligatori. Non solo: le Indicazioni sono uno strumento flessibile, per andar incontro ai rapidi cambiamenti della società, e hanno sostituito i Programmi quando si è spinto sull’autonomia delle scuole, in un contesto di maggior libertà ma anche di maggior responsabilità. I Programmi, invece, hanno una funzione di omologazione: sono documenti che indicano contenuti specifici e obbligatori da seguire in tutte le scuole.
In Italia “L’alternarsi dei governi ha provocato l’avvicendarsi di posizionamenti più o meno ideologici, di battaglie identitarie, di promesse, di riforme abortite e controriforme chirurgiche, di provvedimenti e contro-provvedimenti a spot. Non è un caso che la scuola finlandese funzioni: è frutto di una iniziale intesa “istituzionale” fra le forze di governo e le forze di opposizione, che hanno disegnato un’idea di scuola condivisa, fortemente autonoma e decentrata ma coesa e centralizzata nelle funzioni di controllo e valutazione in uscita degli studenti ” - scrive Gabriele Benassi in un articolo di Scuola 7.
(Nuove Indicazioni o “rivendicazioni” nazionali?)
Quali sono le novità più significative nel passaggio tra le nuove e le vecchie indicazioni?
Ne presentiamo qui di seguito alcune, ma consigliamo una lettura attenta di tutto il documento:
- Recupero della manualità e della scrittura corsiva.
- Promozione della lettura e della memorizzazione poetica.
- Esplicitazione delle conoscenze fondamentali per ogni disciplina.
- Il ritorno del latino.
- Approccio STEM che unisce tecnologia e concretezza.
- Nuova prospettiva storica che valorizza le radici occidentali.
- Introduzione dell’Intelligenza artificiale.
- Centralità del docente come regista del percorso formativo.
- Maggiore coinvolgimento delle famiglie nel patto educativo.
Proviamo ad approfondirle!
1. Recupero della manualità e della scrittura corsiva
Uno degli aspetti più innovativi, ma anche più discussi, delle Nuove indicazioni 2025 è il recupero della manualità come elemento cardine dell’apprendimento, a partire dalla riscoperta della scrittura corsiva. “Alcuni hanno criticato questo come un anacronistico ritorno al passato – spiega la coordinatrice Perla – ma esistono solide evidenze neuroscientifiche che dimostrano come la calligrafia sviluppi la coordinazione occhio-mano e la capacità di organizzazione spaziale”.
La questione viene vista in un modo diverso dall’AID (Associazione Italiana Dislessia) che sottolinea l’eccessiva enfasi posta sull’apprendimento del corsivo. Il documento, infatti, afferma che “la scrittura è fondamentale e va curata con particolare attenzione, a partire dall’apprendimento del corsivo e della calligrafia”. Questo cambiamento segna una netta differenza rispetto alle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, in cui il corsivo non veniva menzionato e l’eccessiva enfasi potrebbe portare all’obbligatorietà del corsivo per tutti i bambini fin dai primi giorni di scuola primaria, senza tenere conto delle difficoltà che possono incontrare gli studenti con DSA (disturbi specifici di apprendimento), in particolare quelli con disgrafia.
Le Linee guida degli studenti con DSA del 2011 suggeriscono, invece, un approccio più graduale, iniziando con lo stampato maiuscolo, più accessibile percettivamente, prima di introdurre lo stampato minuscolo e il corsivo, che risultano più complessi. Insomma, valorizzare la scrittura manuale e il corsivo può essere positivo, ma solo con un approccio flessibile e inclusivo, che non annulli le esigenze di questi studenti.
(Nuove Indicazioni 2025: dimenticati i suggerimenti delle Linee Guida 2011 per il diritto allo studio degli studenti con DSA?)
2. Promozione della lettura e della memorizzazione poetica
Le nuove Indicazioni nazionali spingono sulla promozione della lettura e della memorizzazione poetica. È previsto che gli studenti leggano almeno tre libri all’anno, incentivando l’abitudine alla lettura e l’ampliamento delle competenze linguistiche e cognitive. Inoltre, lo studio e la memorizzazione delle poesie sono considerati strumenti fondamentali per sviluppare la sensibilità estetica e la capacità di apprezzare la bellezza della lingua, in quanto contribuiscono allo sviluppo del pensiero critico e riflessivo e stimolano la creatività degli studenti.
3. Esplicitazione delle conoscenze fondamentali per ogni disciplina
Le nuove Indicazioni nazionali introducono aggiornamenti nei contenuti disciplinari, nei campi di esperienza e nelle metodologie didattiche, in alcuni casi in continuità con il documento del 2012, in altri con l’aggiunta di elementi aventi l’obiettivo di portare avanti un modello di scuola, basato sulla disciplina, sulla ripresa del passato e delle tradizioni.
(Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2025)
Le modifiche riguardano sia la scuola dell’infanzia che il primo ciclo di istruzione, con particolare attenzione alla struttura del curricolo, alla valutazione degli apprendimenti e all’integrazione di nuove competenze.
(Approfondimento nello scaricabile 2_E per le altre discipline cosa cambia con le Nuove Indicazioni nazionali 2025?)
4. Il ritorno del latino
Lo studio del latino (un’ora alla settimana in seconda e terza secondaria di primo grado) non sarà obbligatorio, ma servirà a “comunicare e rafforzare la consapevolezza della relazione storica che lega la lingua italiana a quella latina e a rendere evidente come il latino costituisca un’eredità condivisa e un elemento di continuità tra le diverse culture europee”, afferma la dottoressa Perla in un articolo di TUTTOSCUOLA. Infatti, nel nuovo documento si sottolinea l’importanza del ruolo del latino: “Il latino abitua al ragionamento, alla logica e migliora la conoscenza della nostra lingua. È un patrimonio che non possiamo permetterci di perdere”.
Si spera che per l’introduzione del latino sia stata valutata anche la necessità di una riformulazione delle classi di concorso e dei quadri orari, per evitare il rischio di una diffusione disorganica dell’insegnamento, affidata a iniziative isolate.
(Approfondimento nello scaricabile 2_E per le altre discipline cosa cambia con le Nuove Indicazioni nazionali 2025?)
5. Approccio STEM che unisce tecnologia e concretezza
Interessante l’approccio, che trova piena applicazione anche nell’ambito delle discipline STEM, che sta per Science (scienza), Technology (tecnologia), Engineering (ingegneria) e Mathematics (matematica): un vero e proprio metodo di insegnamento che mira a superare i confini tra teoria e pratica, dal concreto all’astratto.
“Le STEM non devono essere insegnate come discipline separate, ma devono essere collegate tra loro, partendo dall’esperienza concreta e collegandole alla realtà quotidiana. Solo così riusciremo a stimolare la creatività e l’innovazione“, ha affermato la dottoressa Perla.
“Nell’era della rivoluzione digitale – continua Perla – la commissione STEM ha lavorato sul paradosso di una generazione iperconnessa, ma spesso analfabeta rispetto ai meccanismi tecnologici che utilizza quotidianamente”.
Il documento propone quindi un doppio binario: da un lato un’alfabetizzazione digitale critica e consapevole, dall’altro un ritorno alle attività manuali e laboratoriali. “Non si tratta di spontaneismo – chiarisce la coordinatrice – ma di fornire metodo e strumenti per arrivare a quell’autogoverno che rappresenta l’obiettivo finale di ogni percorso educativo”.
Un altro aspetto fondamentale è l’integrazione delle arti con le scienze: passaggio da STEM a STEAM, dove la A sta per “Arti”.
(Donne e discipline STEM)
(Nuove competenze e nuovi linguaggi nei progetti del PNRR)
6. Nuova prospettiva storica che valorizza le radici occidentali
La questione storia e identità rappresenta la pagina più discussa del documento.
La frase che ha generato maggiori polemiche è senza dubbio quella che recita “Solo l’Occidente conosce la storia”.
Ma, secondo la dottoressa Perla, la frase è stata completamente fraintesa.
“La commissione storica, coordinata dal professor Ernesto Galli della Loggia, intendeva semplicemente sottolineare come il triangolo Roma-Gerusalemme-Atene abbia elaborato per primo gli strumenti concettuali per interpretare criticamente il divenire storico”.
(Approfondimento nello scaricabile 1_La Storia nelle nuove Indicazioni Nazionali 2025)
7. Introduzione dell’Intelligenza artificiale
“Il tema delle competenze digitali è centrale nelle nuove Indicazioni, anche per far apprendere l’uso corretto e proficuo delle tecnologie (e dell’IA, che ne è l’ultima frontiera) non solo a scuola ma nella vita.
Si tratta di competenze chiave per la cittadinanza che permettono di orientarsi nell’universo digitale e di rafforzare identità ed autonomia” si legge a pag. 13. Infatti, l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (IA) emerge come una delle novità più significative di questo documento, ma se ne prevede l’uso con prudenza e senso critico, attribuendo il ruolo centrale agli insegnanti affinché ne venga fatto un utilizzo consapevole e responsabile per promuovere una vera e propria educazione alla cittadinanza digitale: “Gli insegnanti – si legge nel documento – hanno il dovere di conoscere e capire le potenzialità della IA. E in aula di spiegare le logiche di funzionamento di dispositivi e piattaforme”.
E ancora “L’IA offre certamente grandi opportunità per l’istruzione a condizione che il suo uso sia guidato da chiari principi etici.
Per conseguire il suo pieno potenziale, essa dovrebbe essere integrata in un contesto in cui le dimensioni umane e sociali dell’apprendimento siano rafforzate e non ‘sostituite’ e in cui prevalga una mediazione chiaramente orchestrata dalla persona dell’insegnante”.
(Modelli didattici innovativi con il digitale)
8. Centralità del docente come regista del percorso formativo
Da queste nuove Indicazioni emerge la volontà di un riconoscimento del ruolo insostituibile del docente. Un docente autorevole non autoritario.
“Troppo spesso si dimentica che un insegnante è magis, di più, e che è il volano del desiderio di apprendere di un allievo. Come tale, è un punto di riferimento essenziale del suo percorso di formazione. L’allievo, infatti, non sceglie di desiderare di imparare, sceglie il modello che sa stimolarlo in tale direzione. E il ‘modello’ è l’esempio di un maestro, esempio fondamentale affinché il desiderio dell’allievo non resti allo stato di pura tensione psicologica ma si orienti verso degli oggetti definiti che sono le esperienze e i contenuti del curricolo”, si legge a pag. 10.
9. Maggiore coinvolgimento delle famiglie nel patto educativo
“Viviamo una stagione molto difficile di comunicazione con le famiglie”, denuncia con preoccupazione Loredana Perla.
“I genitori spesso sono in competizione con gli insegnanti, mettendo sotto valutazione il lavoro della scuola”. Occorre ricostruire un efficace rapporto scuola/famiglia, nel rispetto dei rispettivi ruoli educativi per rinsaldare quel patto educativo che si è rotto da decenni.
Si tratta di ricostruire un clima di fiducia reciproca che permetta di trovare un nuovo equilibrio per poter collaborare per il bene degli studenti.
E la valutazione?
All’insegna della continuità la prima frase: “La valutazione nella scuola del primo ciclo si configura come un processo educativo complesso, dinamico, collegiale e multidimensionale, che accompagna lo studente nella costruzione della propria identità e nel riconoscimento delle proprie potenzialità.” (pag.20)
Crea, però, qualche perplessità leggere nel nuovo documento la valutazione definita a volte “ processo” a volte “atto”, ma poi tranquillizza vedere scritto che, per gli insegnanti, “valutare significa accompagnare, promuovere fiducia nelle proprie capacità e alimentare il desiderio di apprendere e crescere.
Nelle sue diverse articolazioni – diagnostica, iniziale, in itinere, finale – la valutazione permette di cogliere il percorso di apprendimento nel suo farsi, valorizzando la dimensione processuale e dinamica dell’apprendimento, e di restituire agli alunni e alle famiglie una visione chiara del cammino intrapreso, ponendosi quindi come “ponte”, ossia come strumento di dialogo continuo tra docenti e alunni, tra scuola e famiglia.” (pag.20)
Non solo. Significativa è anche la conferma che la valutazione deve restituire “un quadro dinamico e processuale del percorso formativo, che non si limita alla padronanza di saperi disciplinari, ma abbraccia anche competenze trasversali, che, secondo la recente Legge 22 del 19 febbraio 2025, devono essere promosse nei percorsi scolastici accanto alle competenze cognitive.
“Le competenze richiedono un processo di osservazione e valutazione sistematica e rigorosamente documentata (con strumenti adeguati: ad es. rubriche, griglie di osservazione, scale, ecc.), integrando fonti di evidenza diverse e coinvolgendo attivamente l'alunno nella riflessione sul proprio apprendimento. Per questo motivo, è fondamentale alleggerire l’impianto valutativo, ridurre gli adempimenti burocratici e favorire pratiche documentali che restituiscano una rappresentazione autentica del percorso scolastico. La certificazione, in questo quadro, non si limita a registrare il livello di competenze acquisite, ma si fonda su una valutazione processuale che guarda alla complessità dell’esperienza formativa. Essa tiene conto della relazione tra i saperi disciplinari, le competenze trasversali e gli aspetti legati alla cittadinanza, individuando nel profilo educativo in uscita la cornice di riferimento condivisa”. (pag.21)
Si parla anche di valutazione autentica e si invitano i docenti a una progettualità creativa che sappia adattarsi ai contesti e dialogare con le famiglie, costruendo un’alleanza educativa fondata su trasparenza e corresponsabilità.
In definitiva, la valutazione nella scuola del primo ciclo “si configura come un processo sistematico e in continuo divenire che coinvolge in profondità tanto l’agire professionale dei docenti quanto il benessere e la crescita degli studenti: le nuove Indicazioni nazionali intendono promuovere una cultura della valutazione il cui fine ultimo resti sempre quello di sostenere l’apprendimento, promuovere la crescita e valorizzare le potenzialità individuali.” (pag.21)
Sul tema della valutazione l’ANP (Associazione Nazionale Presidi) propone una maggiore coerenza e continuità tra gli strumenti valutativi utilizzati nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado per favorire un approccio integrato, in grado di valorizzare la complessità dell’esperienza educativa, collegando conoscenze disciplinari, competenze trasversali e cittadinanza, approccio che ancora manca… e non per colpa delle nuove Indicazioni.
E la scuola d’infanzia?
Ci sembrano interessanti le osservazioni dei dirigenti scolastici di ANP anche riguardo agli spazi e ai tempi della scuola dell’infanzia.
L’ANP ha evidenziato un limite nella sezione dedicata alla scuola dell’infanzia, dove il collegamento con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 del DM 334/2021 risulta parziale: “Il documento si sofferma solo sugli aspetti della professionalità docente, tralasciando il ruolo dello spazio e del tempo come componenti essenziali.”
E suggerisce di “recuperare i concetti di 'spazio come terzo educatore' e 'tempo come variabile pedagogica', particolarmente rilevanti anche in relazione agli obiettivi del PNRR.
(Nuove Indicazioni nazionali, presidi ANP: “Docente ‘innamorato’ non solo della propria disciplina, ma soprattutto degli alunni”)
Concludiamo con le parole della coordinatrice Loredana Perla: “Le commissioni sono tutte al lavoro in questo momento per recepire le osservazioni migliorative e giungere alla redazione definitiva dei testi… e il testo finale risulterà arricchito e, io spero, utile a fronteggiare una crisi dell’istruzione che è sotto gli occhi di tutti.”
(Scuola, Perla (Commissione MIM): facciamo chiarezza sulle indicazioni Nazionali)
BIBLIO/SITOGRAFIA
- Indicazioni 2025 - Scuola dell’infanzia e Primo ciclo di istruzione - Materiali per il dibattito pubblico
- Indicazioni nazionali e nuovi scenari
- Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2025
- Nuove Indicazioni Nazionali, Perla: "Necessarie per affrontare le nuove esigenze educative". Le novità presentate in Senato
- Nuove Indicazioni 2025: dimenticati i suggerimenti delle Linee Guida 2011 per il diritto allo studio degli studenti con DSA?
- Dure critiche delle società storiche alle Nuove Indicazioni Nazionali. Il webinar di Tuttoscuola
- L’Intelligenza Artificiale entra nella Scuola: le Nuove Indicazioni 2025 per un Futuro dell’Apprendimento
- Nuove Indicazioni o "rivendicazioni" nazionali?
- Intelligenza artificiale e latino: ecco le nuove indicazioni nazionali per la scuola
- Scienze: cosa cambia con le Nuove Indicazioni nazionali 2025?
- L’analisi dell’ANP sulla bozza delle Nuove Indicazioni 2025 per il primo ciclo
- Nuove Indicazioni Nazionali/1. Il testo in sintesi
- Nuove Indicazioni nazionali, presidi ANP: "Docente innamorato non solo della propria disciplina, ma soprattutto degli alunni"
- Scuola, Perla (Commissione MIM): facciamo chiarezza sulle indicazioni Nazionali
- Sorpresa: la "nuova" Geografia riscopre il valore delle Relazioni
A cura di Viviana Rossi e Maria Enrica Bianchi

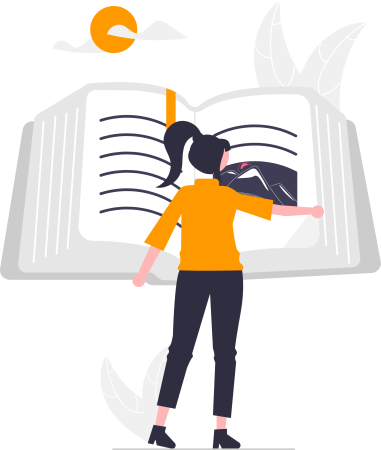

Sei un insegnante?
Scopri la nuova sezione Fai una domanda alle nostre autrici.
Sarà possibile porre alle autrici del blog, Enrica Maria Bianchi e Viviana Rossi, domande di approfondimento sui vari articoli, compilando un semplice form!
Domande e risposte saranno rese pubbliche.
*Per accedere alla sezione usa le tue credenziali Lattes. Se non sei ancora registrato clicca qui!



